Ultime notizie
21 Aprile 2025
20 Aprile 2025
18 Aprile 2025
18 Aprile 2025
17 Aprile 2025
17 Aprile 2025
16 Aprile 2025
L'Italia è immersa in un "letargo esistenziale collettivo", una sorta di "limbo italico", dice il presidente del Censis Giuseppe De Rita. Questa l'immagine triste dell'Italia dipinta dal centro di ricerca nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2015, in cui gli italiani non si muovono più dentro un "progetto generale di sviluppo" , ma da singoli o all'interno di piccoli gruppi sociali.
Nell'Italia dello zero virgola, in cui le variazioni congiunturali degli indicatori economici sono ancora minime, continua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautelativo e non si riaccende la propensione al rischio.
E in questo scenario il settore immobiliare non ne esce bene, per l’ennesima volta. Il Censis registra i dati dell’Abi sulla crescita delle richieste di mutuo (+94,3% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014), e dell’Agenzia delle Entrate (+6,6% di compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Dopo aver osservato come il risparmio degli italiani sia sempre più utilizzato come salvagente per eventuali imprevisti (e quindi per definizione non nell’immobiliare), il Censis segnala come gli italiani vogliano, o siano costretti, ora a mettere a reddito gli immobili di proprietà: “560.000 italiani dichiarano di aver gestito una struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o bed & breakfast, generando un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso. In questa fase, l’esigenza della riallocazione del risparmio in modo più funzionale all’economia reale si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote del proprio reddito aspirate dalla fiscalità”.
Di seguito tutti i punti del Rapporto
Oltre il cash cautelativo, zero rischi: dove andranno i soldi degli italiani. Nel corso dell'anno i principali indicatori economici hanno cambiato segno ed evidenziano movimenti verso l'alto nell'ordine di qualche decimale di punto percentuale. Ma nell'«Italia dello zero virgola» continua a gonfiarsi la bolla del cash cautelativo. Lo dimostra il tasso di inflazione, inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso sforzo della Bce con il quantitative easing, così come gli investimenti nulli. Ammonta a più di 4.000 miliardi di euro il valore del patrimonio finanziario degli italiani. In quattro anni (giugno 2011-giugno 2015) ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2% in termini reali. Negli anni della crisi la composizione del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie ha sancito il passaggio a una opzione fortemente difensiva degli italiani: il contante e i depositi bancari sono saliti da una quota pari al 23,6% del totale nel 2007 al 30,9% nel 2014, mentre sono crollate le azioni (dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al 10,8%). Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giugno 2015) si conferma l'opzione cautelativa degli italiani, con un incremento di 45 miliardi di euro della liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contrazione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno, pari a una riduzione dell'1,2%). La diversità sta però nell'impennata delle quote di fondi comuni, segno di un allentamento della morsa dell'ansia: 108 miliardi in più in un anno (+32,8%). Non si torna però alla fiduciosa assunzione del rischio individuale, consapevoli che l'azzardo lascerebbe impresse cicatrici profonde sulle proprie solitarie biografie personali. D'altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di salvataggio nel quotidiano, visto che nell'anno trascorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito rispetto alle spese mensili. Riguardo agli investimenti, il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo segnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) e l'andamento delle transazioni immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). E si diffonde la propensione a mettere a reddito il patrimonio immobiliare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o bed & breakfast, generando un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso. In questa fase, l'esigenza della riallocazione del risparmio in modo più funzionale all'economia reale si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3% degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo di una riduzione dei servizi pubblici.
Le periferie, vittime dell'intermittenza degli allarmi mediatici e delle politiche. È passato poco più di un anno da quando su tutti i media italiani ha tenuto banco il tema dell'«incendio delle periferie» a seguito dei fatti avvenuti nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Poi l'attenzione è scemata e il tema è di nuovo praticamente scomparso dai radar dei media. La politica nazionale di intervento sui quartieri urbani difficili o degradati si è articolata in un corso più che ventennale (oltre 700 le iniziative finanziate): partita con i primi programmi complessi (come i Programmi di recupero urbano e i Programmi di riqualificazione urbana), nati con finalità solitamente limitate alla riqualificazione edilizia e infrastrutturale; passata poi per le esperienze introdotte dalla Commissione europea (i programmi Urban), che puntavano a rafforzare la dimensione integrata dell'intervento; fino ad arrivare al Piano città. Negli anni 2000 le risorse nazionali sono sostanzialmente venute meno, ma va detto anche che le performance realizzative dei programmi intrapresi nei periodi precedenti sono state spesso deludenti, tranne qualche eccezione.
La questione abitativa dopo la grande crisi. Se tra il 2004 e il 2007 nel mercato immobiliare si era superata la soglia delle 800.000 compravendite l'anno, con la crisi si è scesi prima a 600.000 (triennio 2009-2011), per poi attestarsi negli ultimi quattro anni poco sopra le 400.000 abitazioni scambiate. Se si confrontano i volumi di compravendite delle abitazioni nelle grandi aree urbane del 2007 con quelli del 2014 si vede come nelle cinture metropolitane il mercato si è praticamente dimezzato. Di contro, nei capoluoghi il calo dei volumi di scambio in termini percentuali è in genere assai più contenuto, attestandosi nella maggioranza dei casi tra il 20% e il 30%. Intanto, di anno in anno cresce il numero dei provvedimenti di sfratto (aumentati del 76% dal 2007), riferibili ormai in 9 casi su 10 alla morosità dell'inquilino.
Ripartono i consumi, ma si riapre la forbice sociale. Per la prima volta dall'inizio della crisi, la quota di famiglie italiane che nell'ultimo anno hanno aumentato la propria capacità di spesa risulta superiore a quella delle famiglie che l'hanno invece ridotta (il 25,6% contro il 21,3%). Si tratta di un dato che segna una forte discontinuità con il recente passato: basti pensare che nel 2013 il 69,3% delle famiglie aveva dichiarato che la propria capacità di spesa si era ridotta. Desta comunque preoccupazione il fatto che continua a crescere, sfiorando ormai il 20% del totale, il numero di famiglie che non riescono a coprire tutte le spese con il proprio reddito: circa 5 milioni di famiglie hanno difficoltà a far tornare i conti e tra quelle di livello socio-economico basso la percentuale sale al 37,3%. Anche le previsioni riguardo a redditi, consumi e risparmi danno conferma di un clima generale che sembra virare in positivo. La grande maggioranza delle famiglie prevede comunque di attestarsi sui livelli di reddito, spesa e risparmi dell'anno precedente (rispettivamente, il 79,1%, il 77,6% e il 73,5%).
L'export italiano: un motore potente, ma da revisionare. L'export italiano complessivo (beni e servizi) rappresenta oggi il 29,6% del Pil (era il 25,6% nel 2000, ma era sceso fino al 22,5% nel 2009). Che si tratti di global player stabilmente presenti nei mercati trainanti o di piccoli esportatori di beni con un raggio di azione più limitato, le imprese esportatrici di beni sono attualmente circa 212.000, in crescita negli ultimi anni e in grado di veicolare all'estero un'idea dell'Italia legata ai prodotti di alta qualità, a politiche di marchio efficaci, a prodotti collocati nel top di gamma. Va però segnalata la scarsa incidenza, in termini di valore esportato, della pur massiccia partecipazione delle microimprese. La maggior parte degli operatori (il 64,2% del totale) si addensa nella classe più bassa di valore esportato (sotto i 75.000 euro). Circa 136.000 esportatori determinano un valore dell'export inferiore a 2,4 miliardi di euro: un'inezia rispetto al valore totale delle esportazioni italiane (lo 0,6%). In media, si tratta di poco meno di 17.000 euro ad esportatore. I grandi esportatori, quelli che esportano merci per un valore che eccede i 50 milioni di euro, sono solamente lo 0,5% del totale (961 soggetti), ma realizzano da soli quasi la metà dell'export italiano (circa 191 miliardi di euro). Se poi si guarda al numero di Paesi dove l'Italia esporta, va segnalata una miriade di soggetti (più di 91.000) che hanno come riferimento un solo Paese. Per contro, sono poco più di 4.300 le aziende che vendono i loro prodotti e servizi in più di 40 Paesi esteri, realizzando però il 43% circa del fatturato italiano all'estero.
L'imprenditoria straniera: una proliferazione in attesa di rappresentanza. Oggi gli stranieri residenti in Italia sono poco più di 5 milioni, ma possiamo stimare che al 2030 arriveranno a 8,3 milioni. Di questi, 7 milioni abiteranno al Centro-Nord. Qui la quota degli stranieri residenti, oggi poco sopra il 10%, si attesterà intorno al 17%, cioè ci sarà un cittadino straniero ogni cinque italiani. Nel Mezzogiorno invece rimarrà piuttosto bassa e non raggiungerà il 6% della popolazione. In prospettiva, sarà decisiva la capacità del Paese di passare da una logica emergenziale, improntata alla precarietà delle soluzioni, a una reale integrazione nel corpo sociale e nel tessuto economico di quella parte ormai consistente dei nuovi arrivati che hanno un progetto di inserimento a medio-lungo termine nella società italiana. Negli ultimi anni della crisi, l'occupazione degli stranieri residenti in Italia ha continuato a crescere, registrando un saldo positivo di oltre 260.000 occupati, laddove l'occupazione italiana è diminuita in tutti i settori economici. E tra il 2008 e il 2014 il numero dei titolari d'impresa stranieri è cresciuto di più del 30%, mentre quello degli italiani è diminuito di più del 10%. Pertanto, l'incidenza percentuale degli imprenditori stranieri sul totale è aumentata dal 9,2% al 12,9%..
La crisi dell'auto come fenomeno economico, sociale e culturale. Lo shock che ha colpito di recente il mondo dell'auto suggerisce qualche riflessione che può andare al di là delle analisi sulla perdita di reputazione del gruppo Volkswagen e del made in Germany nel suo complesso, il cui successo si basa in gran parte sull'affidabilità tecnologica. Tra il 2007 e il 2014 le immatricolazioni in Italia da parte dei privati si sono dimezzate, e gli acquisti delle famiglie sono passati dal 77,3% del totale nel 2009 al 62,6% del 2014. Nel frattempo crescono le quote di immatricolazioni da parte delle aziende e soprattutto dei noleggiatori. Proprio questi ultimi, che nel 2015 supereranno per la prima volta la percentuale del 20% del totale, rappresentano la proiezione al futuro del ruolo dell'auto nelle società avanzate: soggetti che vendono servizi di mobilità (in varie forme e destinazioni) e che intermediano il rapporto tra le aziende di produzione di beni per la mobilità privata e una collettività che sarà via via più orientata a utilizzarli, ma non necessariamente a possederli.
Imprese zavorrate dalla Pubblica Amministrazione. L'uscita dalla crisi, la stabilizzazione dei processi di ripresa e il recupero di competitività non possano prescindere dall'eliminazione di quello che si ravvisa come un handicap strutturale rappresentato da un sistema amministrativo inefficiente, ingombrante e costoso. La situazione è ulteriormente inasprita dalla produzione normativa regionale. Nel corso del 2013 le Regioni hanno fatto registrare complessivamente l'approvazione di 711 leggi e 398 regolamenti, facendoci schizzare al primo posto in Europa per produzione normativa, con valori più alti della Germania e che pesano il triplo della Spagna. Si aggiunga che ogni tentativo di semplificazione normativa sembra approdare a risultati insoddisfacenti: la Commissione parlamentare per la semplificazione ammette che per ogni 10 norme abrogate ne entrano in vigore 12 nuove di zecca. Senza che molte di esse, però, riescano a diventare operative, per il gioco perverso dei decreti attuativi che spesso rimangono lettera morta. A marzo 2014, dei 1.277 decreti necessari per mettere in moto le leggi approvate durante i governi Monti e Letta ne erano stati varati appena 462: poco più di un terzo di quelli previsti.
Giovani imprenditori: un'«impresa» possibile. L'Italia ha il più ampio numero di giovani lavoratori autonomi tra i principali Paesi europei: sono 941.000 (nella classe 20-34 anni), seguiti da 849.000 inglesi e 528.000 tedeschi. Il nostro Paese può contare anche su un bacino di potenziali start up vitale e in continuo fermento. Il 15% dei giovani italiani (16-30 anni) ha intenzione di avviare una start up nei prossimi anni. E sono circa 7.000 i giovanissimi titolari d'impresa in più oggi rispetto al 2009 (+20,4%) in alcuni e ben caratterizzati settori, riscuotendo preziosi risultati sul piano personale e di sistema. Tra i segmenti più dinamici un ruolo particolare è svolto dall'area della ristorazione e della ricettività, nella quale operano quasi 20.000 titolari d'impresa al di sotto dei 30 anni (il 9,8% del totale).
Donne e libere professioni alla prova del welfare. Negli anni più recenti è aumentata la schiera delle libere professioniste, con un saldo positivo di 100.000 occupate tra il 2008 (325.000) e il 2014 (426.000). Si è trattato di nuova occupazione (il saldo del periodo è pari a 63.000 neo-occupati), ma anche di un travaso da altre forme di lavoro. Fatto 100 il numero complessivo di occupate al 2008, il dato riferito al 2014 risulta sostanzialmente invariato (100,7), mentre è stata netta la crescita delle libere professioniste (130,9). La sfida cui oggi è chiamato il mondo libero-professionale è di rafforzare le tutele e gli strumenti di assistenza a sostegno dei lavoratori, in particolare dell'universo femminile. Problemi connessi alla salute, situazioni legate alle responsabilità familiari, la maternità hanno coinvolto nel corso degli ultimi cinque anni il 37,8% delle professioniste, eventi che in un elevato numero di casi finiscono poi per ripercuotersi direttamente o indirettamente sulla sfera professionale: il 42,7% di quante si sono trovate in una delle situazioni critiche ha dovuto ridurre l'attività lavorativa; il 20%, pur non avendo ridotto l'attività, ha affrontato problemi con clienti, colleghi o altre persone della cerchia familiare o amicale; per un 18,8%, invece, l'attività lavorativa si è interrotta; solo il 18,6% afferma che, malgrado la complessità della situazione, l'attività lavorativa non ne ha risentito in alcun modo. La crisi e i mutamenti in atto all'interno del mondo libero-professionale hanno spinto le Casse di previdenza privatizzate a non limitare il loro ruolo alle sole prestazioni previdenziali. Oltre alla maternità, ambito già presidiato e che oggi vede sfiorare gli 85 milioni di euro di prestazioni erogate dalla Casse, l'offerta di prestazioni sanitarie integrative (78,8 milioni di euro), interventi a sostegno degli iscritti (33,3 milioni per stato di bisogno, malattia, infortunio, assegni per nucleo familiare, ecc.) e ammortizzatori sociali (66,5 milioni), sono cresciuti sensibilmente negli anni della crisi.
Il profilo basso del lavoro. La crisi e le tecnologie digitali e dell'automazione stanno modificando la struttura occupazionale dei Paesi a economia avanzata. La riduzione di 320.000 addetti rispetto al 2011, corrisponde all'1,4% del totale dell'occupazione, sintetizza da un lato una caduta dell'occupazione operaia e artigiana di quasi 600.000 addetti, dall'altro l'incremento di quasi 180.000 unità per il personale non qualificato (+7,9%), cui si aggiungono circa 100.000 addetti in più nelle categorie professionali medio-alte. Le previsioni per l'Italia al 2025 segnalano incrementi per quanto riguarda i dirigenti (+68%), le professioni intellettuali e scientifiche (+23%), le professioni tecniche intermedie (+18%). Più contenuta la dinamica positiva del personale non qualificato (+3,6%) e negativa quella concernente gli impiegati (-1,2%), mentre il lavoro nel terziario e nell'agricoltura, così come il lavoro artigiano e operaio, mostrerebbero una sostanziale riduzione, con variazioni che raggiungono il 23% in ambito agricolo.
Occupazione globale, mobilità del lavoro e riconfigurazione dei flussi. Il quadro dell'occupazione globale è oggi dato da un totale delle forze di lavoro che nel 2014 ha raggiunto quasi 3,4 miliardi di unità, di cui circa 263 milioni sono riconducibili ai Paesi a più basso reddito, mentre 685 milioni risiedono nei Paesi più ricchi e 534 milioni nei Paesi appartenenti all'Ocse, mentre in Cina se ne contano 802 milioni e in India toccano i 488 milioni. L'occupazione totale è pari a 3,1 miliardi di unità, di cui 249 milioni presenti nei Paesi più poveri, 631 milioni nei Paesi più ricchi, 490 nei Paesi Ocse, mentre la Cina da sola mostra un volume pari a 765 milioni di occupati e in India l'occupazione sfiora i 470 milioni. L'area della disoccupazione è stimata a livello mondiale a un tasso del 6% sul totale delle forze di lavoro (pari a circa 200 milioni di persone), sale all'8% nei Paesi Ocse, scende al 5% nei Paesi a più basso reddito, mentre il tasso di disoccupazione cinese è ugualmente al 5% (oltre 40 milioni di persone) e l'India registra un tasso di disoccupazione del 4% (circa 20 milioni). Lo spostamento di ampie masse della popolazione mondiale è uno dei principali fenomeni cui stiamo assistendo. Oggi sono più di 200 milioni i migranti che attraversano le frontiere. Di questi, 90 milioni sono lavoratori migranti, anche temporanei, e rappresentano tra il 2,5% e il 3% della popolazione mondiale. In alcuni Paesi, come Israele, Kuwait, Qatar e Singapore, la popolazione straniera raggiunge anche il 40% del totale. Australia e Canada presentano quote di popolazione straniera che si aggirano intorno al 20%, mentre gli Stati Uniti sono il Paese di destinazione che in termini assoluti ospita il maggior numero di stranieri, pari a quasi 43 milioni. Seguono la Russia con 12,3 milioni e la Germania con 10,8 milioni. I Paesi a più alto volume di migranti in uscita sono il Messico con 10,1 milioni, l'India con 9,1 milioni e il Bangladesh con circa 6 milioni. La popolazione urbana a livello mondiale ha superato nel 2014 i 3,8 miliardi di unità, di cui 1,1 miliardi presenti all'interno dei Paesi avanzati, mentre più di 2,7 miliardi risiedono nelle grandi aree urbane dei Paesi a basso e medio reddito. In totale, circa il 53% della popolazione mondiale vive in città che ormai sfuggono a una perimetrazione certa e hanno una concentrazione di diverse migliaia di persone per chilometro quadrato. Nei Paesi più ricchi la quota di urbanizzati raggiunge l'81%, mentre nei Paesi a basso e medio reddito è del 43%.
Scenari metropolitani: la crescita differenziata delle megacity. La concentrazione di popolazione in forme urbane ha assunto negli ultimi decenni un carattere estensivo e articolato. Oggi in Italia abbiamo 4 grandi regioni urbane composte da circa 900 comuni, con una popolazione complessiva pari a 17 milioni di abitanti, all'interno delle quali troviamo le prime tre città del Paese (Roma, Milano e Napoli), nonché la conurbazione delle quattro città venete (Venezia, Padova, Treviso e Vicenza). Poi abbiamo 7 medie regioni urbane, con circa 260 comuni e 8,9 milioni di abitanti, dove si trovano Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari. Poi ancora 7 piccole regioni urbane, con circa 180 comuni e 4,4 milioni di abitanti, tra cui Verona, Palermo e Catania. Esiste dunque un'armatura urbana di livello superiore che raccoglie poco più di 30 milioni di abitanti e in cui si addensa metà della popolazione italiana (il 49,7%). La rilevanza di queste regioni urbane è destinata a crescere ulteriormente in futuro. Le previsioni demografiche elaborate dal Censis stimano che al 2030 queste regioni urbane nel loro insieme vedranno aumentare la popolazione dell'8,6% contro un incremento complessivo della popolazione italiana stimato nell'ordine del 3,4%. Raccoglieranno quasi 33 milioni di abitanti, con un'incidenza sulla popolazione totale pari al 52,3%. Per molte delle aree-regioni urbane del Centro-Nord la crescita sarà ben più rilevante: la megaregione lombarda incentrata su Milano crescerà dell'11%, l'area romana del 15%, l'area veronese e quella fiorentina del 16%, l'asta emiliana quasi del 20%.
Milano e Roma: dall'Expo al Giubileo, due città sotto i riflettori. Milano e Roma rappresentano, in ambiti diversi, i nodi che mettono in rete il Paese con i contesti esterni, come dimostrano due grandi eventi come l'Expo (145 Paesi partecipanti, 21 milioni di visitatori in sei mesi) e il Giubileo (attesi 33 milioni di pellegrini e visitatori nel corso dell'Anno Santo). Per avere un'idea del livello di polarizzazione dei beni culturali nella capitale, basta pensare che, considerando il numero di visitatori (37,6 milioni nel 2014) dei primi 50 siti culturali a pagamento italiani (musei, aree archeologiche e monumenti a gestione statale, comunale o privata), ben il 44% è localizzato a Roma e dintorni. Firenze, che si colloca in seconda posizione, assorbe solo il 14% dei visitatori.
Andamento economico e domanda di trasporto: un rapporto che perde di linearità. Gli esercizi previsionali basati sulle proiezioni del Pil e dell'occupazione attestano un aumento della popolazione che esprime domanda di mobile (ossia di tutti coloro che si spostano giornalmente, per diverse esigenze e con diverse modalità di trasporto) variabile dal 4,1% all'8,5% nell'intervallo 2015-2030. Nello scenario che prevede il maggiore incremento della popolazione mobile, attestandola a 42,4 milioni, la popolazione che utilizza l'auto passerà dai 26,2 milioni del 2010 ai 27,5 del 2030. Aumenteranno anche gli utenti del trasporto pubblico, da 3,8 a 4,5 milioni. A questi fenomeni si associano i cambiamenti recentissimi, e non ancora consolidati nei numeri, del passaggio dal possesso dei veicoli al loro semplice utilizzo in time sharing.
La riforma dei porti: barra al centro per recuperare competitività. A fronte del calo dei volumi di merce imbarcata e sbarcata nei porti italiani, nel resto del mondo le merci movimentate sono cresciute di anno in anno. Fatto 100 il livello dei traffici marittimi al 2006, il dato italiano è pari oggi a 72,7 a fronte di un dato aggregato mondiale che si attesta a 124,5. Contribuiscono a queste scarse performance i gravami burocratici connessi all'export: un costo che si materializza nei 19 giorni che mediamente occorrono in Italia per ottenere la documentazione amministrativa per esportare un container, a fronte dei 10 necessari in Francia e Spagna, ai 9 in Germania e ai 7 nei Paesi Bassi.
Il rimbalzo occupazionale selettivo dopo la lunga crisi. Dall'entrata in vigore del Jobs Act, il mercato del lavoro ha visto rimbalzare l'occupazione di 204.000 unità. Siamo ancora lontani dal recuperare la situazione pre-crisi, dato che nel terzo trimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2008, mancano all'appello 551.000 posti di lavoro. La disoccupazione si riduce all'11,9%: una cifra molto lontana però dal 6,7% del 2008. Per quanto riguarda i giovani (15-24 anni) si registra un crollo dell'occupazione, proseguito anche nel 2015, con un recupero ora di appena 9.000 unità rispetto al primo trimestre. Il loro tasso di disoccupazione è praticamente raddoppiato in sei anni, con un picco del 42,7% nel 2014 e poi un calo di 1,4 punti tra il primo e il terzo trimestre di quest'anno. L'occupazione femminile, invece, ha guadagnato 64.000 posti di lavoro in sei anni e si registra ancora un incremento di 35.000 occupate tra il primo e il terzo trimestre del 2015. E se nel 2008 i lavoratori più anziani (55-64 anni) erano poco meno di 2,5 milioni, nel 2014 erano diventati 3,5 milioni e continuano a crescere, con un aumento di 91.000 unità nei primi sei mesi dell'anno. Si consolida la presenza nel mercato del lavoro della componente straniera, che ha superato i 2,3 milioni di occupati, con un incremento di 604.000 unità tra il 2008 e il 2014 e di 77.000 nella prima metà dell'anno. Intanto, permangono criticità che rischiano di cronicizzarsi: i giovani che non studiano e non lavorano (i Neet) sono 2,2 milioni, la sottoccupazione riguarda 783.000 addetti, il part time involontario 2,7 milioni di occupati e la Cassa integrazione ha superato nel 2014 la soglia del miliardo di ore concesse, corrispondenti a circa 250.000 occupati equivalenti. E poi ci sono i workaholic loro malgrado: negli ultimi dodici mesi, 11,3 milioni di italiani hanno lavorato regolarmente o di tanto in tanto durante il weekend, 10,3 milioni oltre l'orario formale senza il pagamento degli straordinari, 7,3 milioni a distanza (da casa o in viaggio), 4,1 milioni hanno lavorato di notte, 4 milioni hanno fatto piccoli lavoretti saltuari.
La piattaforma di ripartenza (e trasformazione) dell'Italia: la geografia dei vincenti ridisegnata dal driver dell'ibridazione. Oggi il primo fattore di riposizionamento dei vincenti è il rapporto con la globalità, profondamente modificato dall'abbattimento delle barriere e dei costi di ingresso grazie al digitale. Chi negli anni delle ristrettezze interne ha vinto ogni pulsione protezionista o di pura trincea, ed è andato verso l'esterno assumendosene i rischi e accettando le sfide, adesso incassa il dividendo di tale scelta. Le esportazioni valgono il 29,6% del Pil. Nonostante il contraccolpo causato dalla crisi dei mercati emergenti, hanno continuato a crescere anche negli anni della crisi e nei primi nove mesi dell'anno segnano un +4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Vincono i produttori di macchine e apparecchiature, con un surplus di 50,2 miliardi di euro nel 2014, e l'Italia oggi è leader nella produzione di macchinari per produrre altri macchinari. Vince l'agroalimentare, che nell'anno dell'Expo fa il boom di esportazioni (+6,2% nei primi otto mesi del 2015) e riconquista la leadership nel mercato mondiale del vino (con oltre 3 miliardi di export). Vincono i comparti consolidati dell'abbigliamento (+1,4% di export nei primi otto mesi dell'anno), della pelletteria (+4,5%), dei mobili (+6,3%), dei gioielli (+11,8%). E vince un settore trasversale per vocazione come quello creativo-culturale, con 43 miliardi di export. Ma a contare veramente non è un pur importante segno positivo negli indicatori congiunturali. Il vero «X factor» sta in una rinnovata ibridazione di settori e competenze tradizionali che produce un nuovo stile italiano: il risultato di questa ibridazione è una trasformazione dei settori tradizionali. Il design e la moda ne sono l'archetipo (ibridazione di qualità, saper fare artigiano, estetica, brand). Oggi il successo della gastronomia italiana ha agganciato lo sviluppo della filiera agroalimentare, legandola anche al turismo, alle bellezze paesaggistiche e culturali del Paese, grazie anche al volano delle piattaforme digitali.
L'onda montante del turismo polimorfo. Il settore turistico ha registrato un costante incremento dei flussi anche negli anni della crisi. Dal 2000 il numero complessivo di arrivi nel territorio italiano è aumentato del 33,3%, raggiungendo nel 2014 la cifra record di 106,7 milioni, con 378,2 milioni di presenze. L'incremento maggiore riguarda gli arrivi di stranieri: sono stati 51,7 milioni nell'ultimo anno (+47,2% tra il 2000 e il 2014) e pesano ormai per il 48,4% del totale. Ma anche i turisti italiani sono aumentati del 22,4% nel periodo: sono stati 55 milioni nell'ultimo anno. E i dati più recenti disponibili, riferiti al primo semestre del 2015, confermano il trend di crescita: +1,8% di arrivi complessivi e +3,2% di turisti stranieri rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. La platea degli estimatori del nostro Paese è sempre più globalizzata. Dal 2010 a oggi sono i cinesi (+137,9%), i coreani (+70,8%), i russi (+56,6%) e i brasiliani (+31,4%) gli stranieri per i quali si registrano le più forti variazioni positive. E il turismo diventa diffusivo: gli arrivi nelle località marine (+17,2% nel triennio 2010-2013) e montane (+15,2%) ora crescono più di quelli nelle città di interesse storico e artistico (+13,2%), tradizionalmente mete prioritarie per gli stranieri soggiornanti in Italia. Dal lato dell'offerta, nel periodo 2010-2014 gli arrivi nelle strutture extralberghiere (+23,8%) sono aumentati molto più di quelli nelle strutture alberghiere (+16,5%): +42,6% nei bed & breakfast, +33,2% negli agriturismi, +27,9% negli alloggi in affitto. E poi c'è il caso Roma: il Colosseo nel 2014 ha avuto 6,2 milioni di visitatori (erano 2,5 milioni nel 2000: +148%), i Musei Vaticani 5,8 milioni di visitatori (3 milioni nel 2000: +93%), Castel Sant'Angelo 1 milione di visitatori (590.000 nel 2000: +69%).
La ritrovata fiducia che premia i beni durevoli: auto ed elettrodomestici. Il ciclo declinante del consumo di beni durevoli parte dal 2007 e si protrae fino al 2013, poi registra una ripartenza: dalla seconda metà del 2014 e per tutto il 2015 sono proprio i beni durevoli a trainare la ripresa dei consumi familiari. Le analisi previsionali presentano uno scenario incoraggiante. Tra coloro che in famiglia assumono la responsabilità degli acquisti principali, la quota di chi dichiara di avere fiducia nel futuro (il 39,8%) supera quella di chi non vede segnali positivi (il 22,4%), mentre la parte restante (il 37,8%) è ancora incerta. Questa ritrovata fiducia si riflette sulle intenzioni di acquisto: il 5,7% delle famiglie (più del doppio rispetto all'anno scorso) ha intenzione di comprare un'auto nuova (se andrà così, si avranno nel 2016 circa 1,5 milioni di immatricolazioni, come non si vedeva dal 2008), il 5,7% nuovi mobili per la casa, l'11,2% nuovi elettrodomestici (quasi 3 milioni di famiglie), il 9,2% ha intenzione di ristrutturare l'immobile. Sono potenzialità nei consumi da scongelare.
Verso nuovi stili di consumo digitali e relazionali. Il Censis stima in 15 milioni gli italiani che fanno acquisti su internet, 2,7 milioni hanno comprato prodotti alimentari in rete negli ultimi dodici mesi e l'home banking è praticato dal 46,2% degli utenti del web. E il successo della sharing economy rende ancora più evidente i nuovi stili di consumo. Nell'ultimo anno il 4% degli italiani (circa 2 milioni) ha utilizzato il car sharing, ma tra i giovani la percentuale sale all'8,4%.
Il cambio di look dei piani terra delle città. I cambiamenti più diffusi nelle città in questi ultimi anni vanno ricercati nei «piani terra». Tra il 2009 e il 2015 si osserva una riduzione dell'11,2% dei negozi di ferramenta, dell'11% dei negozi di abbigliamento, del 10,8% delle librerie, del 10,5% delle macellerie, del 9,9% dei negozi di calzature, dell'8,7% dei negozi di articoli sportivi. Crescono invece del 37% i take away, del 15,5% i ristoranti, del 10% i bar, dell'8,2% le gelaterie e pasticcerie. Ciò dipende da tre ragioni: il ridotto capitale necessario all'avvio di queste attività, la pervasività del cibo nella nostra vita quotidiana, l'iniziativa di molti stranieri attivi nel commercio.
L'immigrazione apocalittica e i processi minuti di integrazione. Gli stranieri in Italia inseguono una traiettoria di crescita verso la condizione di ceto medio, differenziandosi così dalle situazioni di concentrazione etnica e disagio sociale che caratterizzano le banlieue parigine o le innercities londinesi, dove l'islam radicale diventa il veicolo del rancore delle seconde e terze generazioni per una promessa tradita di ascesa sociale. Tra il 2008 e il 2014 in Italia i titolari d'impresa stranieri sono aumentati del 31,5% (soprattutto nel commercio, che pesa per circa il 40% di tutte le imprese straniere, e nelle costruzioni, per il 26%), mentre le aziende guidate da italiani diminuivano del 10,6%. A fine settembre i migranti sbarcati in Italia sono stati 132.071, il 10% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi nove mesi del 2015 le 42.801 domande di asilo hanno portato nel 23,6% dei casi all'attribuzione della protezione umanitaria, nel 15,8% di quella sussidiaria e nel 5,5% al riconoscimento dello status di rifugiato. L'altra metà, al netto dei possibili ricorsi, andrà incontro a un diniego e all'obbligo, non sempre rispettato, di lasciare il nostro Paese. Erano 70.652 gli stranieri irregolari rintracciati in Italia nel 2008, ma la cifra si è ridotta a 30.906 nel 2014 e sono stati 23.112 nei primi nove mesi del 2015. I rimpatri hanno avuto un picco nel 2011 (25.163), seguito da un netto calo fino a oggi: 10.559 tra gennaio e settembre del 2015. Lo sforzo delle istituzioni per ampliare la rete dell'accoglienza è testimoniato dal numero di posti più che quadruplicati in due anni, dai 22.000 del 2013, prevalentemente concentrati nelle regioni meridionali, ai 98.000 del settembre 2015, distribuiti in tutte le regioni. Ma l'integrazione è un processo che, se certamente va accompagnato dall'alto, si compie nella fisiologia dei comportamenti quotidiani. Il 66% dei giovani italiani di 18-34 anni si dichiara favorevole ad accogliere nel nostro Paese le persone che fuggono da guerre e miseria, mentre tra gli anziani la percentuale è molto più bassa (37,2%).Il 44% degli italiani, inoltre, ritiene che è cittadino italiano chi nasce sul suolo italiano, per il 33% chi vive in Italia per un certo periodo di tempo minimo (non importa dove sia nato), per il 19% chi ha genitori italiani. Lo «ius soli» (il diritto di cittadinanza agli immigrati acquisito automaticamente con la nascita in un territorio) è quindi il criterio privilegiato.
Politica e società ancora fuori sincrono: la politica come performance delle riforme. Quanto più lo Stato non rappresenta un baluardo sicuro per gli individui rispetto alle minacce al loro benessere, tanto più la politica deve farsi performance: deve tagliare con il passato ed essere percepita come veloce, efficace, risolutiva. Ma resta un deficit di fiducia nei cittadini. La globalizzazione continua a dividere gli italiani: conserva un valore positivo solo per il 39%, il 47% ne dà invece un giudizio negativo, il 14% è incerto. Sul libero mercato gli italiani esprimono un consenso largo: il 66% ne dà un giudizio positivo, solo il 25% si mostra critico, il 9% non ha un'opinione in proposito. Ma allo stesso tempo il 39% considera positivamente il protezionismo, contro il 46% che esprime una valutazione negativa e il 15% di dubbiosi. Solo il 23% degli italiani ritiene che l'Ue tenga opportunamente conto dei nostri interessi nazionali (contro una media europea, riferita ai rispettivi interessi nazionali dei diversi Paesi membri, pari al 40%), mentre due terzi (il 67%) sono convinti del contrario. Gli italiani si distinguono per un livello di fiducia accordato alle diverse istituzioni politiche più basso di quello espresso dai concittadini europei: solo quote minime hanno fiducia nei partiti politici (9%), nel Governo (16%), nel Parlamento nazionale (17%), e la percentuale di quanti ripongono fiducia nell'operato delle autorità regionali e locali (il 22%) è meno della metà di quanto si riscontra in media nel resto del continente (47%). Bassi anche i giudizi di fiducia su Commissione europea (39%) e Bce (35%).
Il restringimento del welfare che alimenta gli squilibri sociali. La spesa sanitaria pubblica, cresciuta dal 2007 al 2010 da 101,9 miliardi di euro a 112,8 miliardi, negli ultimi anni ha registrato una inversione di tendenza, con una riduzione tra il 2010 e il 2014, attestandosi nell'ultimo anno a 110,3 miliardi. La spesa sanitaria privata delle famiglie, invece, dal 2007 al 2014 è passata da 29,6 a 32,7 miliardi, raggiungendo il 22,8% della spesa sanitaria totale. La percentuale di famiglie a basso reddito in cui nell'ultimo anno almeno un membro ha dovuto rinunciare o rimandare prestazioni sanitarie è elevata: il 66,7%. E sono 7,7 milioni le persone che si sono indebitate o hanno chiesto un aiuto economico per pagare cure sanitarie. Anche l'andamento del Fondo nazionale per le politiche sociali testimonia il progressivo ridimensionamento dell'impegno pubblico, nonostante il parziale recupero degli ultimi tre anni: 1.565 milioni di euro nel 2007, 43,7 milioni nel 2012, 400 milioni nel 2015 (-74,4% nell'intero periodo). Un andamento simile riguarda anche il Fondo per la non autosufficienza, che nel 2012 non è stato neanche finanziato, per poi salire a soli 400 milioni di euro nell'ultimo anno.
Il ricentraggio decisionale e la deriva politica dei territori. La quota di liste civiche sul totale delle liste che si presentano alle elezioni nei Comuni capoluogo è salita dal 30% al 65% tra il 2007 e il 2015. Tale crescita corrisponde all'esigenza delle élite locali di affermare il proprio diritto all'autogoverno, relativizzando il peso dei partiti politici di appartenenza. Il fenomeno del trasformismo è poi in crescita. Ad oggi il tasso in Parlamento (eletti che cambiano schieramento rispetto agli eletti totali) è del 19,5% (non arrivava al 19% nell'intera Legislatura precedente). I «cambi di casacca» sono in media 5 al mese nei Consigli regionali, 6,1 nel valzer parlamentare: un valore molto più alto di quello della precedente Legislatura (3,0).
Le «Considerazioni generali» del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015
Senza progettazione per il futuro, la cultura collettiva è prigioniera della cronaca e del consenso d'opinione. Famiglie e imprese restano in un recinto securizzante, ma inerziale: un limbo italico fatto di mezze tinte. Generoso l'impegno politico a ridare slancio alla dinamica economica. La società continua a fare il suo sviluppo basato sulla storia di lungo periodo, la capacità inventiva, i processi oggi vincenti: un impasto che connota il «resto», che non accede alle luci del proscenio, ma anima il «racconto» reale del Paese
Roma, 4 dicembre 2015 - Un letargo esistenziale collettivo e la vittoria della pura cronaca. C'è oggi una pericolosa povertà di interpretazione sistemica, di progettazione per il futuro, di disegni programmatici di medio periodo. Prevale una dinamica d'opinione messa in moto da quel che avviene giorno per giorno. È la vittoria della pura cronaca, che inietta nella vita quotidiana il virus della sconnessione. Lo si vede nella disarticolazione strutturale del nostro sistema. La composizione sociale è di antica e sempre più intensa molecolarità: vincono l'interesse particolare, il soggettivismo, l'egoismo individuale e non maturano valori collettivi e una unità di interessi. Crescono così le diseguaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle strutture intermedie di rappresentanza che l'hanno nel tempo garantita. A ciò corrisponde una profonda debolezza antropologica, un letargo esistenziale collettivo, dove i soggetti (individui, famiglie, imprese) restano in un recinto securizzante, ma inerziale. In sintesi, ne deriva una società a bassa consistenza e con scarsa autopropulsione: una sorta di «limbo italico» fatto di mezze tinte, mezze classi, mezzi partiti, mezze idee e mezze persone.
Il rilancio del primato della politica. Quest'anno c'è stato però un generoso impegno a ridare slancio alla dinamica economica e sociale del Paese attraverso il rilancio del primato della politica, con un folto insieme di riforme di quadro e di settore, e la messa in campo di interventi tesi a incentivare propensione imprenditoriale e coinvolgimento collettivo rispetto al consolidamento della ripresa. E c'è stata la ricerca del consenso d'opinione sulle politiche avviate, per innescare nella collettività una mobilitante tensione al cambiamento, una riscoperta di ottimismo e un recupero reputazionale. Ma questo impegno fatica a fomentare nel corpo sociale una reazione chimica, un investimento collettivo, la necessaria osmosi tra politica e mondi vitali sociali. L'elemento oggi più in crisi è la dialettica socio-politica: non riesce a pensare un progetto generale di sviluppo del Paese a partire dai processi portanti della realtà ed esprime una carenza di élite. Così, la cultura collettiva finisce per restare prigioniera della cronaca (scandali, corruzioni, contraddittorie spinte a fronteggiarli, ecc.).
Cosa resta oltre la pura cronaca e il volontarismo della politica? I processi di sviluppo reale del Paese. È uno sviluppo fatto di basi storiche, capacità inventiva e processi vincenti. La società fa il suo cammino innanzitutto valorizzando la nostra storia di lungo periodo: la «saggezza popolare» che ci ha fatto sempre scegliere bene nei momenti cruciali della nostra evoluzione, il decoroso modello di sviluppo creato a partire dagli anni '70, una composizione sociale poliedrica (lontana dagli schemi di classe e di ceto), una pur discussa forza sommersa dei comportamenti economici e sociali (dal risparmio al lavoro individuale), una territorialità non indistinta, la fedeltà continuata nel primato della diversità (delle opinioni e dei comportamenti). In secondo luogo, esprimendo una certa dose di invenzione: la nostra società è capace di innovare in un continuo susseguirsi di processi e poteri soft (lontano dalla impressività dei poteri hard), gestisce la realtà attraverso un empirismo continuato con capacità di autoregolazione, esprime una forte tensione a una organizzazione socio-politica di tipo poliarchico, ha bisogno di liberare le energie individuali dalle burocrazie e dalle procedure uniformanti. Così, nell'indifferenza del dibattito socio-politico, si va costruendo uno sviluppo fatto di basi storiche, capacità inventiva e naturalezza dei processi oggi vincenti. Esempio ne sono i giovani che vanno a lavorare all'estero o tentano la strada delle start up, le famiglie che accrescono il proprio patrimonio e lo mettono a reddito (con l'enorme incremento, ad esempio, dei bed & breakfast), le imprese che investono in innovazione continuata e green economy, i territori che diventano hub di relazionalità (la Milano dell'Expo come le città e i borghi turistici), la silenziosa integrazione degli stranieri nella nostra quotidianità. A ciò si accompagna anche un'evoluzione più strutturata, con il nuovo made in Italy che si va formando nell'intreccio tra successo gastronomico e filiera agroalimentare, nell'integrazione crescente tra agricoltura e turismo (con l'implicito ruolo del patrimonio paesaggistico e culturale), nel settore dei «macchinari che fanno macchinari» (la vera punta di diamante della manifattura italiana).
La società del «resto». Nelle fasi di sviluppo precedenti, la domanda di riconoscimento della società era rivolta al mondo della rappresentanza sociale, alla dialettica socio-politica e al potere statuale. Ma oggi sono tre chiamate in causa cui è difficile dare seguito, perché sono tre realtà in crisi profonda. E anche perché la società appare ormai poco propensa a esprimersi come soggetto di domanda. Si esprime invece in quella dinamica spontanea descritta sopra, che però è considerata residuale: un «resto» rispetto ai grandi temi che occupano la comunicazione di massa. Ma il «resto», che finora non è entrato nella cronaca e nel dibattito socio-politico, comincia ad affermare una sua autoconsistenza. Nei movimenti tettonici che ci portano avanti «vince il resto»: quel che non accede al proscenio e alle luci della visibilità. È proprio dal «grande resto» che può cominciare a partire la riappropriazione della nostra identità collettiva.
De Rita: «Il resto ha segnato la storia dello sviluppo italiano degli ultimi cinquant'anni, che è anche la storia del Censis che lo ha raccontato». «Cosa resta oggi del grande processo di globalizzazione vista come occidentalizzazione del mondo? Il policentrismo di tanti diversi sviluppi e la crescita faticosa di una poliarchia», ha detto Giuseppe De Rita, presidente del Censis, illustrando il Rapporto annuale dell'istituto. «Nella nostra storia, il resto del mito della grande industria e dei settori avanzati è stata l'economia sommersa e lo sviluppo del lavoro autonomo. Il resto del mito dell'organizzazione complessa e del fordismo è stata la piccola impresa e la professionalizzazione molecolare. Il resto della lotta di classe nella grande fabbrica è stata la lunga deriva della cetomedizzazione. Il resto dell'attenzione all'egemonia della classe dirigente è stata la fungaia dei soggetti intermedi e la cultura dell'accompagnamento. Il resto del primato della metropoli è stato il localismo dei distretti e dei borghi. Il resto della spensierata stagione del consumismo (del consumo come status e della ricercatezza dei consumi) è la medietà del consumatore sobrio. Il resto della lunga stagione del primato delle ideologie è oggi l'empirismo continuato della società che evolve. E i processi di sviluppo reale del Paese qui descritti sono il resto delle tante discussioni sulla guerra degli ultimi giorni».
È online il nuovo numero di REview. Questa settimana: JLL: Q1 2025, 2,7 mld di investimenti capital markets in Italia
Notizie Correlate
18 Aprile 2025
Red
Red
Red
Red
16 Aprile 2025
Red
Red
23 Ottobre 2024
Studio Belvedere & Partners
23 Ottobre 2024
Red
Video Correlati
01 Aprile 2025






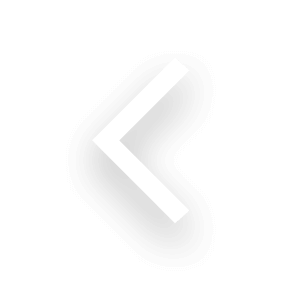
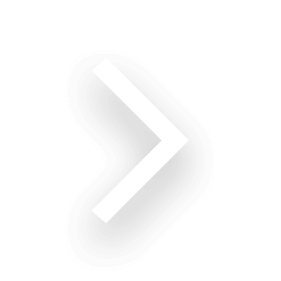


.jpg)


